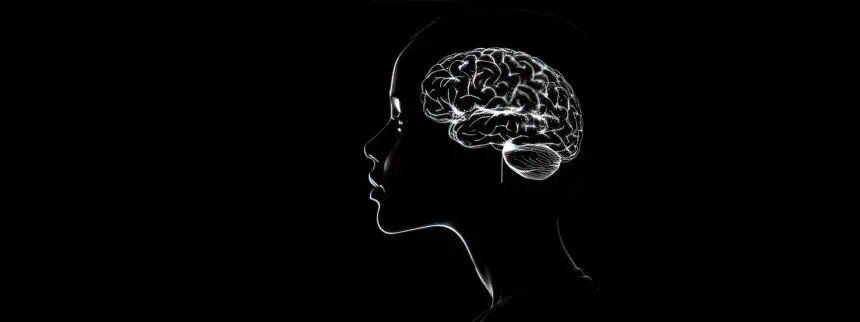Una scintilla improvvisa sotto un cielo di pregiudizi
Nel 1919, una conferenza sull’eclissi solare cambiò il corso della vita di una giovane studentessa di Cambridge, Cecelia Payne, e con lei quello dell’astronomia moderna. Aveva solo 19 anni quando ascoltò il racconto di un’osservazione astronomica avvenuta al largo dell’Africa, e qualcosa in lei scattò: da quel momento decise che avrebbe dedicato la vita alle stelle.
Nonostante l’Inghilterra dell’epoca non concedesse laurea magistrale alle donne, Payne non si fermò: emigrò negli Stati Uniti, si iscrisse all’Università di Harvard, e iniziò un cammino destinato a rivoluzionare la comprensione dell’universo.
Una scoperta incompresa: l’universo è fatto di idrogeno
All’inizio del XX secolo, gli astronomi credevano che le stelle fossero fatte degli stessi elementi della Terra. Il pensiero dominante era geocentrico, non in senso cosmico, ma nella convinzione che la composizione chimica dell’universo fosse un riflesso di quella terrestre.
Nel 1924, mentre era dottoranda a Harvard, Payne eseguì una sofisticata analisi spettrale sfruttando i dati dell’Osservatorio di Harvard. Applicando la fisica quantistica e i nuovi modelli di ionizzazione, giunse a una conclusione rivoluzionaria: le stelle erano composte quasi interamente da idrogeno ed elio, in quantità un milione di volte superiori a quanto ritenuto possibile fino ad allora.
Fu un’idea radicale, tanto più scioccante perché proposta da una donna giovane, straniera e senza titoli accademici ufficialmente riconosciuti in patria. Eppure, aveva ragione.
Il rifiuto e la strategia di sopravvivenza scientifica
Quando Payne presentò la sua tesi, ricevette un secco rifiuto dal più influente astronomo americano dell’epoca, Henry Norris Russell, direttore dell’Osservatorio di Princeton. Le disse che si sbagliava. Così, per non rischiare di perdere tutto, modificò la sua tesi, inserendo la frase ambigua “quasi certamente non così prominente”, lasciando però intendere che credeva nei suoi calcoli.
Questa astuzia fu fondamentale. Anni dopo, Russell stesso confermò la validità delle sue teorie, pubblicandole… e prendendosi inizialmente il merito. La comunità scientifica, col tempo, riconobbe l’errore e restaurò il ruolo centrale di Payne nella scoperta.
Una carriera pionieristica sotto il peso del sessismo
Nonostante il suo contributo fondamentale, Payne-Gaposchkin affrontò un mondo scientifico ostinatamente maschile e ostile. Lavorava nell’ombra, sottopagata rispetto ai colleghi maschi, e per anni le fu negata una cattedra, pur contribuendo in modo continuo all’astrofisica.
Ma la sua perseveranza ebbe la meglio. Fu la prima donna a diventare professoressa a Harvard, salendo tutti i ranghi fino a diventare presidente del Dipartimento di Astronomia. Costruì una famiglia con l’astronomo Sergei Gaposchkin, con cui collaborò scientificamente, e aprì la strada a generazioni di donne nella scienza.
L’eredità di una rivoluzionaria
Cecelia Payne-Gaposchkin non fu solo la prima a determinare la composizione delle stelle, ma anche un simbolo della lotta per l’uguaglianza nel mondo scientifico. La sua influenza è viva ancora oggi. Vera Rubin, la scienziata che scoprì la materia oscura, la citò come una fonte d’ispirazione fondamentale per la sua carriera.
Tre anni prima della sua morte, nel 1979, Payne ricevette un premio alla carriera dall’American Astronomical Society. Ironia della sorte, il riconoscimento portava il nome proprio di Henry Norris Russell, il primo a dirle che aveva torto.
Payne-Gaposchkin ha dimostrato che credere nella propria intuizione scientifica, anche contro il mondo intero, può cambiare la storia. E il cielo, da allora, non è più stato lo stesso.