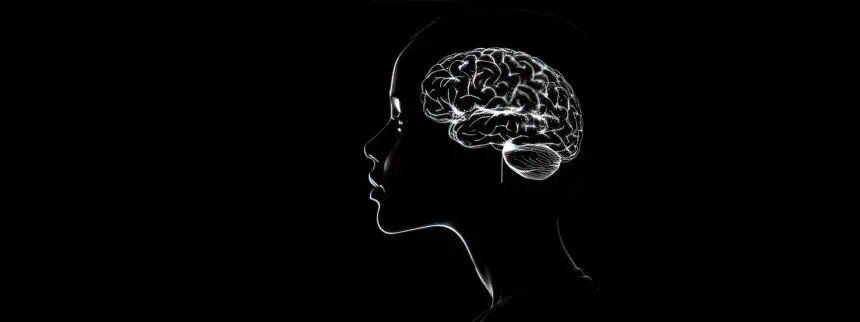Una molecola già impiegata nel trattamento di sarcomi dei tessuti molli potrebbe rappresentare una svolta nella ricerca di una cura per l’HIV. Questo composto, noto come EBC-46, ha dimostrato la capacità di riattivare temporaneamente il virus all’interno delle cellule infette, permettendo al sistema immunitario di individuarlo ed eliminarlo. Secondo uno studio pubblicato su Science Advances, questa scoperta potrebbe rivoluzionare il modo in cui viene affrontato il virus.
Un’arma contro il virus che si nasconde
L’HIV è un virus che, se non trattato, può portare all’AIDS, una sindrome potenzialmente letale. Attualmente, i farmaci antiretrovirali riescono a impedire la replicazione del virus, rendendo la malattia gestibile. Tuttavia, questi trattamenti sono costosi e richiedono una somministrazione a vita, senza eliminare completamente l’infezione. “Se interrompi la terapia, il virus può tornare in modo devastante,” spiega Matthew Marsden, virologo dell’Università della California, Irvine.
Per questo motivo, i ricercatori hanno cercato nuove strategie per colpire il virus alla radice, mirando alle cellule in cui si nasconde.
La scoperta del composto EBC-46
Il team guidato da Paul Wender della Stanford University e da Matthew Marsden ha individuato una possibile soluzione nel EBC-46, un composto di origine naturale estratto dai semi degli alberi di blushwood, che crescono nelle foreste pluviali australiane.
Questa molecola è stata originariamente sviluppata per trattare i sarcomi dei tessuti molli ed è già stata approvata dalla Food and Drug Administration (FDA) per uso oncologico nel 2024, dopo aver ottenuto risultati promettenti anche nel trattamento dei tumori nei cani.
La sua efficacia è legata all’attivazione della proteina chinasi C, che stimola le cellule infette dall’HIV a uscire dallo stato latente. Una volta esposte, queste cellule possono essere identificate e distrutte dal sistema immunitario. Secondo lo studio, il 90% delle cellule latenti viene riattivato grazie a EBC-46, un risultato che ha sorpreso gli stessi ricercatori.
Perché l’HIV è così difficile da eliminare?
Uno dei motivi per cui l’HIV è così difficile da debellare è la sua capacità di rimanere nascosto all’interno dell’organismo. Sebbene i farmaci antiretrovirali ne impediscano la replicazione, alcune particelle virali si rifugiano in cellule dormienti e non vengono riconosciute dal sistema immunitario.
“Il virus si annida in cellule latenti molto rare,” spiega Marsden. Questo fenomeno rende il trattamento dell’HIV simile a un gioco del gatto e del topo: anche se il carico virale viene ridotto, il virus può riemergere in qualsiasi momento.
Dalla ricerca sui composti organici una nuova speranza
Wender e il suo team lavorano da oltre 15 anni per trovare un modo per forzare il virus a rivelarsi. Già nel 2008, avevano sperimentato una molecola chiamata prostratina, derivata dalla corteccia di un albero tradizionalmente usato dai guaritori samoani contro l’epatite.
Successivamente, la ricerca si è concentrata su un altro composto, la bryostatina 1, isolata da una creatura marina chiamata bugula comune. Tuttavia, la difficoltà nell’estrazione e l’efficacia limitata – solo il 20% delle cellule latenti veniva riattivato – hanno spinto i ricercatori a cercare alternative più performanti, come il EBC-46.
Un farmaco antitumorale che potrebbe rivoluzionare la lotta all’HIV
Nonostante HIV e cancro siano malattie molto diverse, il meccanismo d’azione del EBC-46 sembra adattarsi a entrambi i contesti. Nel caso dei sarcomi, la molecola attiva specifici antigeni tumorali, facilitando il riconoscimento e l’attacco da parte del sistema immunitario.
Nel caso dell’HIV, il principio è simile: il EBC-46 spinge le cellule infette a rivelarsi, rendendole vulnerabili agli anticorpi. “Vogliamo un metodo sicuro ed efficace per eliminare il virus latente,” afferma Marsden.
Sebbene il farmaco non sia ancora pronto per l’uso clinico contro l’HIV, potrebbe rappresentare un primo passo verso la riduzione della dipendenza dai farmaci antiretrovirali e, potenzialmente, verso una cura definitiva. Wender sottolinea che ci sono ancora diverse questioni da risolvere, tra cui la tollerabilità umana e la variazione della risposta tra i pazienti, ma definisce la scoperta “estremamente promettente”.