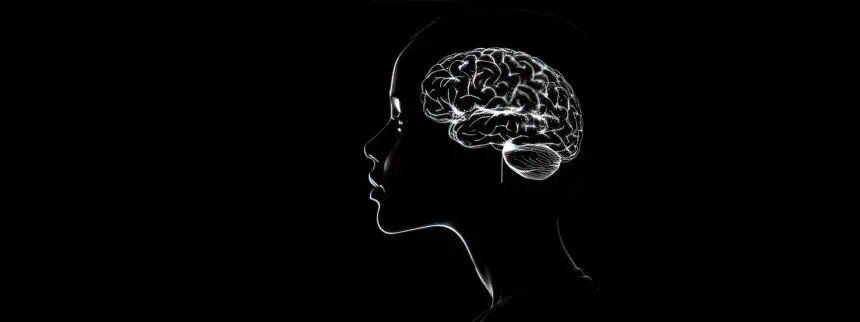Un’importante ricerca ha permesso di ricostruire la chimica delle acque sotterranee all’interno della caldera dei Campi Flegrei, un’area vulcanica di straordinario interesse scientifico. Lo studio, pubblicato sul Journal of Volcanology and Geothermal Research, è stato condotto dall’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca, l’Università di Palermo e l’Università Federico II di Napoli.
Il team di ricercatori, coordinato da Stefano Caliro, ha analizzato 114 campioni di acqua prelevati tra il 2013 e il 2014, rivelando una significativa diversità nelle composizioni chimiche delle falde. Queste informazioni risultano essenziali per comprendere i fenomeni in atto nel sottosuolo, interpretare eventuali segnali precursori di attività vulcanica e monitorare l’evoluzione della crisi bradisismica iniziata nel 2005.
Le diverse tipologie di acque nella caldera
I risultati della ricerca confermano la presenza di una grande variabilità nella composizione delle acque sotterranee, influenzata dai diversi processi geochimici in corso. Nei Campi Flegrei sono state identificate differenti tipologie di acque:
- Acque fredde di origine meteorica, provenienti direttamente dalle precipitazioni;
- Acque termali, formatesi a seguito dell’interazione con i gas vulcanici;
- Acque ad alta temperatura, arricchite da soluzioni saline profonde;
- Acque dell’area Solfatara-Pisciarelli, fortemente influenzate dalla condensazione di vapore ricco di zolfo.
Un monitoraggio continuo per la sicurezza dell’area
Questa ricerca ha gettato le basi per un sistema innovativo di monitoraggio permanente delle acque nella caldera, operativo dal 2018 e in costante aggiornamento. Secondo Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano e co-autore dello studio, i dati raccolti consentono un controllo più efficace dei processi sotterranei, migliorando la capacità di prevedere eventuali fenomeni vulcanici e sismici.
La comprensione della geochimica delle acque flegree rappresenta dunque un tassello fondamentale per la sicurezza della popolazione e la gestione del rischio vulcanico in una delle aree geologicamente più attive d’Europa.