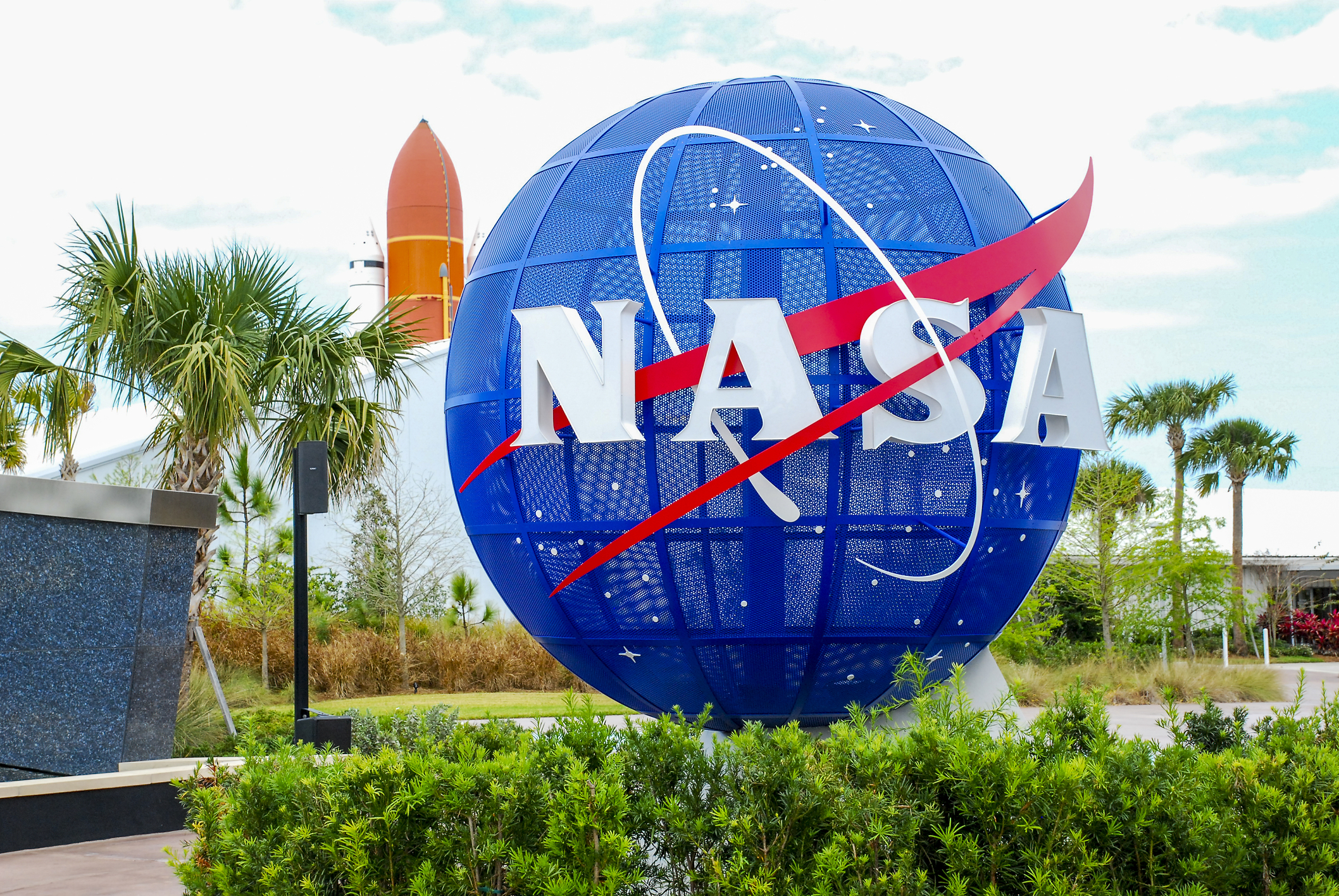
Le aurore boreali sono tra gli spettacoli naturali più affascinanti del nostro pianeta, ma molti dei processi che le generano restano ancora un mistero. La NASA, attraverso due nuove missioni con razzi sonda, spera di chiarire il fenomeno, compresi alcuni aspetti meno noti come le enigmatiche aurore nere. Il lancio è previsto per il 21 gennaio 2025, con i razzi diretti verso i cieli dell’Alaska, un luogo privilegiato per l’osservazione di queste luci danzanti durante l’inverno.
Il meccanismo dietro il fenomeno aurorale
Le aurore sono il risultato dell’interazione tra il vento solare e la magnetosfera terrestre, ovvero la regione dominata dal campo magnetico del nostro pianeta. In seguito a un’intensa attività solare, come un’espulsione di massa coronale, enormi quantità di plasma vengono proiettate nello spazio e, quando raggiungono la Terra, gli elettroni entrano in collisione con i gas presenti nell’alta atmosfera, come ossigeno e azoto. Questa interazione scatena l’emissione di spettacolari bagliori colorati, dando vita alle aurore boreali.
Le nuove missioni della NASA mirano a comprendere con maggiore precisione i dettagli di questi processi fisici, in particolare il motivo per cui tali collisioni avvengono e cosa determina le loro differenti manifestazioni.
Il ruolo dell’accelerazione degli elettroni
Una delle due missioni, denominata GIRAFF (Ground Imaging to Rocket Investigation of Auroral Fast Features), si concentrerà sull’accelerazione degli elettroni all’interno delle aurore. Verranno lanciati due razzi, ognuno diretto verso un diverso tipo di aurora: uno studierà le aurore a pulsazione rapida, che lampeggiano a una frequenza di qualche volta al secondo, mentre l’altro analizzerà le aurore a intermittenza, caratterizzate da lampeggiamenti che possono arrivare fino a 15 volte al secondo.
La differenza tra queste due tipologie di aurore potrebbe risiedere nelle diverse modalità con cui gli elettroni guadagnano energia. Per verificarlo, i razzi raccoglieranno dati fondamentali, tra cui il livello di energia degli elettroni, la loro densità e il tempo di arrivo nell’alta atmosfera.
A caccia delle misteriose aurore nere
L’altra missione, chiamata Black and Diffuse Aurora Science Surveyor, avrà un obiettivo ancora più intrigante: lo studio delle cosiddette aurore nere, note anche come anti-aurore. A differenza delle normali aurore boreali, queste si manifestano come regioni di buio improvviso all’interno di un’aurora luminosa, creando un effetto visivo sorprendente.
Le aurore nere sono già state osservate in passato, ad esempio dalla missione Cluster dell’Agenzia Spaziale Europea, ma la loro origine rimane poco chiara. Gli scienziati ritengono che questi fenomeni siano legati a un cambiamento nella traiettoria degli elettroni provenienti dal Sole. Invece di dirigersi verso la ionosfera terrestre, alcuni elettroni sembrano invertire il loro percorso e tornare nello spazio, creando così delle zone d’ombra nell’aurora.
Per approfondire questo fenomeno, il razzo di Black and Diffuse Aurora Science Surveyor entrerà direttamente nelle regioni in cui si verificano le aurore nere, raccogliendo dati sulle popolazioni di elettroni coinvolte. Gli scienziati sperano così di chiarire il meccanismo che porta questi elettroni a comportarsi in modo così inaspettato.
Un anno di grande attività aurorale
Osservare e studiare le aurore boreali non è semplice, poiché la loro comparsa è imprevedibile. Per massimizzare le possibilità di successo, gli scienziati della NASA utilizzeranno speciali telecamere a terra per tracciare il movimento delle aurore e determinare il momento ideale per il lancio dei razzi. L’obiettivo non è colpire l’aurora in un punto fisso, ma anticiparne la traiettoria e posizionarsi nel punto giusto al momento giusto.
Le nuove missioni arrivano in un periodo particolarmente favorevole: il Sole sta attraversando una fase di massima attività, con un’intensificazione delle tempeste solari. Questo è legato al ciclo di 11 anni del campo magnetico solare, che ha raggiunto il suo massimo nel 2024. Gli effetti di questa intensa attività continueranno a farsi sentire per gran parte del 2025, aumentando la frequenza e l’intensità delle aurore boreali visibili dalla Terra.
Queste missioni non solo offriranno nuove informazioni sui misteri delle aurore, ma potrebbero anche migliorare la nostra comprensione dell’interazione tra il Sole e la Terra, con implicazioni per la meteorologia spaziale e la protezione delle infrastrutture tecnologiche dai fenomeni solari estremi.







