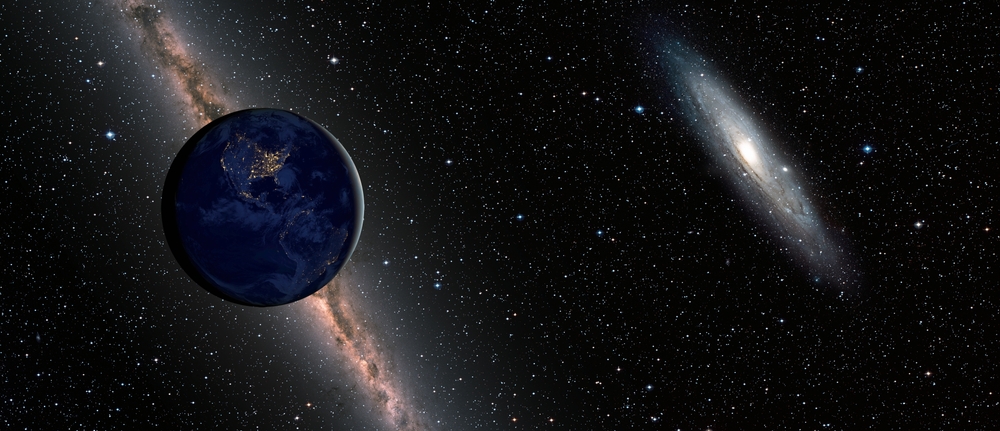
Da sinistra: Mario Lattanzi, Mariateresa Crosta e William Beordo, i tre autori dell’articolo pubblicato su Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP) lo scorso dicembre. Il loro lavoro confronta le curve di rotazione previste da diversi modelli teorici con i dati raccolti dalla Dr3 di Gaia.
Crediti: Mariateresa Crosta/INAF
Un’ipotesi rivoluzionaria per spiegare la rotazione della nostra galassia
Nel 2020, uno studio pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS) aveva sollevato un acceso dibattito nella comunità scientifica. A proporlo era stata Mariateresa Crosta, astrofisica dell’INAF di Torino, che ora torna al centro dell’attenzione con due nuove ricerche di follow-up pubblicate nel 2024: una su MNRAS a marzo e un’altra su JCAP a dicembre.
Entrambi gli articoli, frutto del lavoro di dottorato di William Beordo, approfondiscono il tema della curva di rotazione della Via Lattea, ovvero il grafico che descrive come varia la velocità delle stelle in funzione della loro distanza dal centro galattico.
Questa volta, però, il numero di stelle analizzate è notevolmente superiore: rispetto alla Dr2 di Gaia, utilizzata nel primo studio, i dati della Dr3 offrono circa 130 volte più stelle, consentendo un’analisi più accurata.
L’obiettivo resta lo stesso: dimostrare che la curva di rotazione della nostra galassia può essere spiegata attraverso una geometria rigorosamente relativistica, senza dover ipotizzare l’esistenza di materia oscura o altre modifiche ad hoc alle leggi della fisica.
Ma questa volta gli autori hanno fatto un passo in più, mettendo il loro approccio a confronto con altri due modelli:
- Il modello standard newtoniano, che prevede la presenza di un alone di materia oscura.
- La teoria MOND (Modified Newtonian Dynamics), che modifica la legge di gravitazione per spiegare la rotazione delle galassie senza materia oscura.
I risultati della Dr3 confermano l’ipotesi relativistica? Media INAF ha intervistato Mariateresa Crosta per scoprirlo.
Quali sono i limiti del modello cosmologico LambdaCDM?
Secondo Crosta, la motivazione alla base di questo studio è stata quella di verificare quanto la fisica della nostra galassia sia governata dalla teoria della Relatività generale di Albert Einstein.
«Con la precisione raggiunta da Gaia, pari a un microarcosecondo – l’equivalente di misurare dalla distanza di Giove la dimensione di una stella sulla Mole Antonelliana – diventa indispensabile tenere conto di ogni correzione relativistica», spiega l’astrofisica.
Tradotto in termini più semplici, questo significa che la luce delle stelle viene influenzata dalla presenza di corpi celesti, che ne curvano il percorso attraverso la loro attrazione gravitazionale. Eppure, le curve di rotazione sono sempre state costruite assumendo una fisica newtoniana, ovvero una semplice approssimazione della Relatività generale.
Perché non è stato fatto prima?
Tradizionalmente si è sempre pensato che la velocità delle stelle fosse troppo bassa rispetto a quella della luce per rendere necessaria l’applicazione della Relatività generale.
«Per noi, però, si tratta di una questione scientifico-epistemologica: se i dati di Gaia sono modellati secondo Einstein, allora anche la nostra galassia dovrebbe esserlo», afferma Crosta.
E il miglior test per questa ipotesi è proprio la curva di rotazione galattica, costruita utilizzando le informazioni cinematiche e spettroscopiche fornite da Gaia.
La materia oscura è davvero necessaria?
Uno dei problemi fondamentali della cosmologia è il comportamento delle stelle nelle regioni più esterne delle galassie. Secondo le equazioni di Newton, le velocità stellari dovrebbero diminuire con la distanza dal centro galattico, ma le osservazioni mostrano invece curve di rotazione piatte.
Per risolvere questa discrepanza, il modello LambdaCDM ipotizza la presenza di materia oscura, una forma di materia invisibile che eserciterebbe un’attrazione gravitazionale aggiuntiva.
La teoria MOND, invece, propone una modifica alle leggi della gravità, aumentando la forza gravitazionale in regime di bassa accelerazione.
Ma il modello relativistico di Crosta e colleghi suggerisce un’alternativa: la curva di rotazione può essere spiegata senza bisogno di materia oscura, semplicemente applicando in modo più rigoroso la Relatività generale.
Cosa rende unici i dati di Gaia?
Il vantaggio di Gaia è che permette di misurare con precisione senza precedenti il movimento delle stelle e la loro distanza.
Nel primo studio basato sulla Dr2, il team aveva analizzato circa 6.000 stelle. Con i dati della Dr3, il campione è salito a 800.000 stelle, tutte caratterizzate da orbite stabili nel piano equatoriale galattico.
Questo rende Gaia uno strumento insostituibile per testare le teorie gravitazionali.
Quale modello descrive meglio la rotazione della Via Lattea?
I tre modelli testati – Newtoniano, MOND e Relatività generale – hanno fornito curve di rotazione statisticamente equivalenti.
«Quello che sorprende è che un modello basato sulla Relatività generale, con meno parametri e senza bisogno di componenti ad hoc, funzioni altrettanto bene di un modello che necessita di materia oscura», osserva Crosta.
Questo suggerisce che sia necessario sviluppare nuove soluzioni alle equazioni di Einstein per descrivere in modo più accurato la struttura della galassia.
Cosa significa per la materia oscura e l’energia oscura?
Questi risultati non mettono in discussione l’intera cosmologia moderna, ma sollevano dubbi sulla necessità della materia oscura nelle galassie.
Crosta sottolinea che la presenza di materia ed energia oscura è supportata da altri dati cosmologici, come le osservazioni della radiazione cosmica di fondo. Tuttavia, studiare la Via Lattea con un approccio relativistico potrebbe aiutare a ridefinire il ruolo della materia oscura nell’universo.






